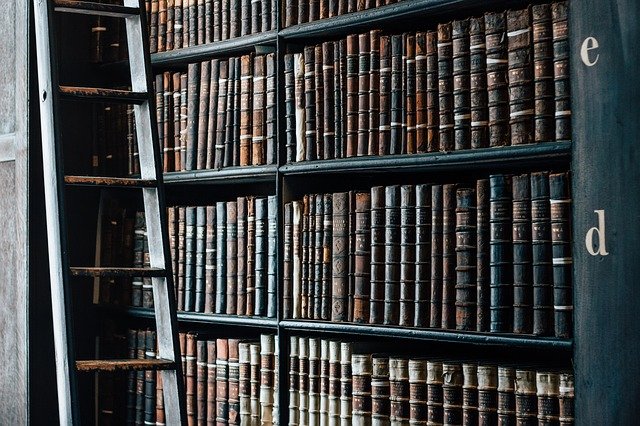Conseguenze, in sede di redazione del ricorso per cassazione, della commistione, in un unico motivo, di più profili di doglianza.
Il redigere un motivo di ricorso per cassazione, in modo da farvi convergere plurimi ed eterogene profili di doglianza, espone ad inammissibilità, laddove non sia possibile ricondurre tali diversi profili, a specifici motivi di impugnazione.
Infatti, le doglianze, anche se cumulate, debbono comunque essere formulate in modo tale da consentire un loro esame separato, come se fossero articolate in motivi diversi, senza quindi confidare alla Corte di Cassazione il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, al fine di ricondurle nell’alveo di uno dei mezzi d’impugnazione consentiti, prima di decidere su di esse (Cass. n. 6734 del 2020)
Pertanto, nella formulazione del motivo di ricorso per cassazione, è bene evitare, se non si vuol incorrere in una pronuncia di inammissibilità, la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei ed incompatibili, facenti riferimento, ad esempio, alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., 1° co., nn. 3 e 5.
Non è infatti consentita la prospettazione e l’analisi di una medesima questione sotto profili antitetici, quali quello della violazione di norme di diritto (che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma) e quello del vizio di motivazione (che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione:Cass. n. 26874 del 2018)
Giova specificare (con riguardo al profilo attinente alla censura di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) che il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge.
Esso, quindi, sottende, necessariamente, un problema interpretativo della stessa norma di legge.
Di per contro, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, condotta sulla base delle risultanze di causa, si colloca al di fuori dell’ambito dell’esatta interpretazione della norma di legge, inerendo, piuttosto, alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui critica è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione, sempre che, beninteso, si traduca in violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., 6° co., individuabile nelle ipotesi (da veicolare come violazione dell’art. 132 c.p.c., 2° co. n. 4, poiché esse danno adito a nullità della sentenza) di: a) “mancanza assoluta della motivazione”; b) “motivazione apparente”; c) “manifesta ed irriducibile contraddittorietà”; d) “motivazione perplessa od incomprensibile”.
Se non dovesse ricorrere alcuna di tali 4 ipotesi, il vizio di motivazione potrà essere dedotto (ex art. 360, co. 1°, n. 5., c.p.c.) esclusivamente per omesso esame di un “fatto storico”, ove, beninteso, abbia formato oggetto di discussione e appaia “decisivo”, ai fini di una diversa soluzione della controversia.
Risulta quindi inammissibile la deduzione di errori di diritto, individuati tramite la mera indicazione della norma asseritamente violata, ma non dimostrati tramite una circostanziata critica delle soluzioni adottate dal giudice di merito, nel risolvere le questioni giuridiche sottese alla controversia.
Mai dimenticare, infatti, che il controllo affidato alla Corte di Cassazione non equivale alla revisione del ragionamento decisorio che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, poichè ciò si tradurrebbe in una nuova formulazione del giudizio di fatto, in contrasto con la funzione morfologicamente assegnata dal sistema al giudice di legittimità (Cass. n. 20012 del 2014).